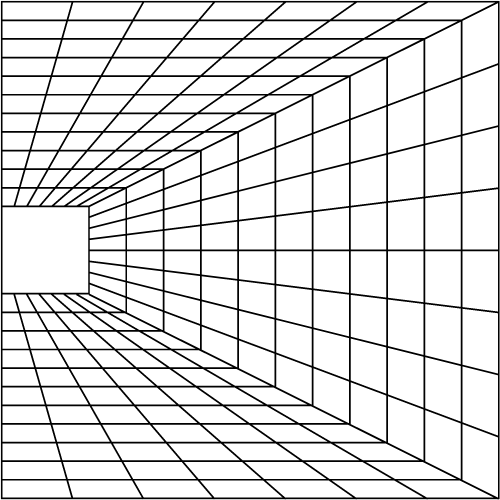Trascrizione dell’intervento tenuto da Francesca Marianna Consonni in occasione della giornata “Occupare l’immaginario” – Olinda, ottobre 2023.
Sono qui con Giuseppe Isgrò, regista della compagnia Phoebe Zeitgeist di cui anche io faccio parte e con Patrizia Moschella, direttrice a NABA della Facoltà di Design della Comunicazione e Docente di Sociologia dei processi culturali e scenari futuri, per partecipare e dare il nostro contributo in questa giornata dedicata ad Antonio o meglio dedicata al pensiero di Antonio, che alberga in tutti noi e fa senso.
Noi ci siamo proposti di affrontare questo contributo da una particolare angolatura, che poi è quella che abbiamo condiviso con Antonio, dando come titolo generale “Interferenze tra Sapere e Potere” che è ovviamente il nervo di tutta la ricerca di Antonio, ma che è anche stato per noi oggetto e metodo di tanto lavoro. Qui presentiamo due ambiti in cui Antonio è stato presente e determinante, scuola e teatro, che sono anche e non a caso i luoghi dove queste interferenze si producono con grande evidenza. Chi lavora nella scuola o nell’arte è immerso in queste interferenze e ne risente a ogni livello, per ogni forma di funzione. Perché qui si annida la matassa? Perché questi sono i luoghi deputati alla costruzione delle narrazioni o – se ci va meglio – alla decostruzione della narrazione. Antonio in questi ambiti ha dato moltissimo, immettendo strumenti a più non posso, sempre là dove c’era bisogno di creare, di dare parola, la parola come strumento di supporto all’analisi, ma anche alla realizzazione artistica.
Noi abbiamo conosciuto Antonio come appunto “datore di parola”, traduttore di Ballard che mettevamo in scena. Ma anche come docente e come performer linguistico, e come performer in scena. Questa, che qualcuno ha chiamato trasversalità o interdisciplinarità, sarebbe da ridefinire e non è comunque una qualità che vada data per scontata.
Siamo tutti costretti a spezzarci su migliaia di attività a causa della contingenza e questa non è trasversalità ma la disgrazia di fare cultura in Italia. Antonio nei passaggi tra le cose manteneva un discorso unico, strutturato attraverso le parole, parole ristrutturate ad ogni singola azione.
Questo è un presidio di complessità: chi protegge la complessità non permette che questa si esaurisca e costruisce per essa ponti e vie di fuga affinché resista ad attacchi e a crolli.
Nella cultura, nella scuola, nel teatro, la complessità è sempre sotto la minaccia di una scomposizione, di una strozzatura, di un’etichettatura. Lavorando con il gruppo Phoebe Zeitgeist, per ogni spettacolo proponiamo al pubblico motivazioni, letture del lavoro al di là del lavoro, perché anche il lavoro nasce come non univoco e inequivocabile. È questa la nostra ricerca. Alle volte andiamo a dare motivazioni individuali, cioè perché tu e perché questo spettacolo, perché dovresti vederlo, perché ti appartiene, in qualche maniera.
Cerchiamo spessissimo anche la relazione con degli intellettuali, affinché ci ritorni sul lavoro una visione, una nuova possibilità di ragionare, una lettura impensata. Giuseppe Isgrò ha sempre voluto inserire all’interno del gruppo di lavoro la figura del dramaturg, consigliere, intellettuale e curatore di motivi altri legati allo spettacolo. Antonio è stato dramaturg per il lavoro teatrale “Note per un Collasso Mentale” tratto da La Mostra delle Atrocità di Ballard, ed è in video come uno stupendevole, perfettissimo Burroughs. Questa non so se sia interdisciplinarietà oppure, semplicemente, competenza e capacità di dare corpo alla parola. Tuttavia, nella richiesta di confronto, ci sentiamo anche rispondere: “non è il mio ambito”, “non è il mio specifico”, “faccio arti visive e non teatro”, “mi occupo di performance e non di parola”, “sono uno studioso di Fassbinder cinematografo ma non di quello teatrale”. Non è antierotico, ospedaliero? Questa idea che l’arte ti possa interessare solo se la puoi curare, e non, come nel caso di Antonio, perché possiedi parola. Questi studiosi si figurano come medici, specialisti di una singola parte, il dito, l’ovaio, il ginocchio. Si vive la cultura come un meraviglioso pacifico giardino botanico in cui prendersi cura neanche di un intero albero fecondo ma solo del ramo su cui si è allocati. Io non vivo in questo Eden e vedo in realtà che chi si occupa di cultura si fa carico di un tutto che mentre viene sorretto, stupra, schiaccia. Antonio invece era atletico e presente nelle politiche di educazione è stato molto vicino a tante creazioni artistiche, a tanti gruppi, a collettivi, si è introdotto nella costruzione di più opere e si è interessato di teatro quando si faceva politico: non è trasversalità, è piuttosto andare dritti come una freccia attraverso tutto ciò che porta al punto. Tutte le volte che si attivava il linguaggio, che si smuoveva la parola, lì troviamo Antonio. Laddove è in gioco il linguaggio, ecco che la situazione si fa politica, questa è Hannah Arendt che conclude meglio di me ogni ragionamento.
E la battaglia del linguaggio non è in nessun modo una battaglia già combattuta, anzi è ogni giorno del tutto nuova. Sono già due guerre in pochi anni che iniziano con Ceci n’est pas un pipe, due guerre che iniziano dicendo questo non è un attacco, questa non è una guerra.
Antonio ha insegnato in Accademie, Master, contesti internazionali, è stato direttore ed è stato sugli scudi. Gli è costato molto. Io ho insegnato con grande onore alla scuola dell’obbligo, la scuola dello Stato, le scuole materne e primarie, dove i bambini di cinque anni mi hanno spiegato molto bene una paradigmatica interferenza tra sapere e potere. Mi hanno spiegato cioè che la scuola è un meccanismo di frustrazione dei saperi: tutte le volte si parte da una personalità unica che si deve adeguare, si adegua, raggiunge il risultato, lo supera, si forma un’autorità, una personalità e nel momento in cui si può spingere sui propri saperi è ora di ricominciare. I bambini di cinque anni sono definiti gli adolescenti dell’infanzia, sono pronti, maturi, capaci di linguaggio, vogliono organizzare saperi, azioni, in base a quello che sanno. Ma ecco che li si mette in prima e divengono primini, ed è ancora tutto da costuire e capiterà ancora altre volte. Il meccanismo imprime un potere sul sapere e lo modera, serve proprio ad attutire quella potenza, quella capacità che viene dal sapere e a tenerlo lì, a dire: poi la utilizzerai, adesso non è il momento.
Se ci fosse una partito politico o un movimento culturale discendesse dalle posizioni di Antonio forse una delle prime battaglie sarebbe la distruzione del sistema scolastico come noi lo conosciamo, la scuola del conflitto.
C’è questa pillola video interessantissima di Antonio, si intitola Elogio del conflitto ed è proprio legata al mondo della scuola. Dice che alla scuola, che non ha più il primato da tempio del sapere, è rimasta un’unica finale utilità: essere il perfetto ambiente protetto per l’esercizio del conflitto.
Io mi sono attenuta alle indicazioni di Antonio e per quindici anni ho organizzato i bambini in una brigata culturale contro lo stato e il potere. Organizzare il conflitto significa anche cercare di stare all’interno del conflitto naturale umano, che c’è sempre, e cercare di allestire delle forme di coabitazione possibile in questo conflitto. A me gli strumenti per vedere queste forme sono arrivati dall’arte contemporanea e ho tenuto fede, costandomi anche qualche amicizia, alla definizione di Antonio. Però, questa scuola del conflitto, che è quella poi che ci è rimasta in mano oggi, è una palestra per una società del conflitto, una società convinta che nella dialettica ci sia la risoluzione del problema e non è mai stato vero, né davvero utile e decisamente non è più bello.
Magari occorrerebbe ripartire da una scuola della complessità in cui i saperi rientrano non perchè dispensati ma perchè utilizzati, in cui gli immaginari sono aperti e in costruzione e in cui non si frena e ammaestra ma si sviluppa e amplia il linguaggio.
In un inciso di una frase del suo contributo Antonio apre infatti un varco e ci dice, proprio come faceva lui ovvero mettendo tra le virgole un quintale di senso o possibili panorami inesplorati con vie e sottopassi per raggiungerli, che infine a scuola si potrebbe fare anche esercizio del fatto che il conflitto, talvolta, non si redime, rimane lì e non deve essere risolto. Qui l’idea di complessità che a me piace portare oggi e che penso che, nell’ambito dell’arte e nell’ambito dell’educazione, noi abbiamo il dovere di continuare a presidiare. La traccia di Antonio, il suo modo, tutto quello che ci ha lasciato, in questo ci aiuta.