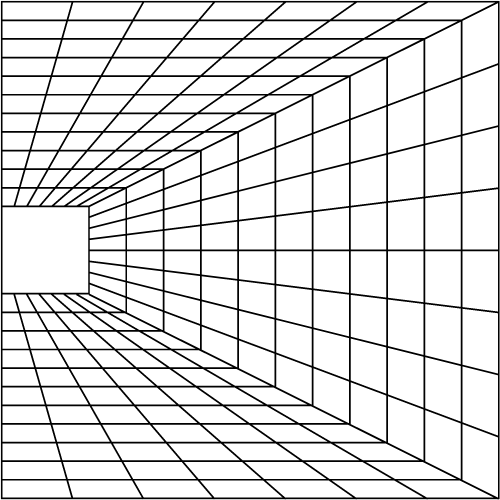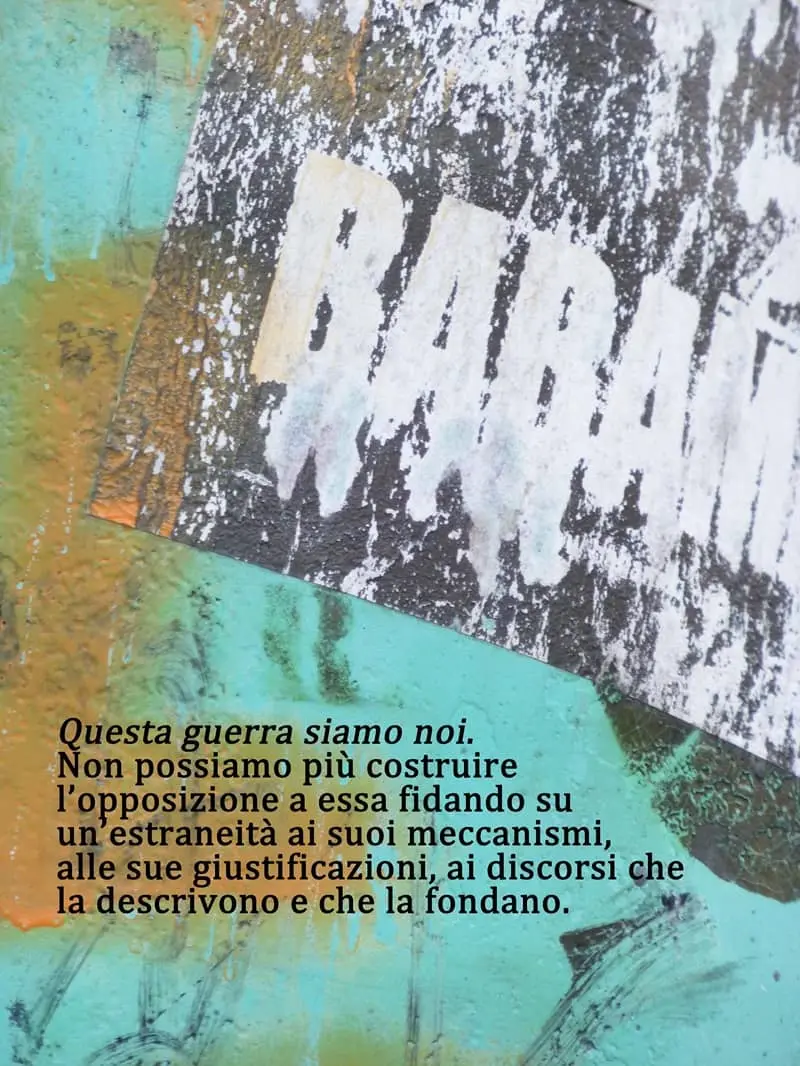di Antonio Caronia
Questa guerra siamo noi. Non potremmo chiamarcene fuori neanche se volessimo, non potremmo sentirla estranea neppure se decidessimo di chiudere gli occhi di fronte alle sue conseguenze più estreme – e potremmo farlo, se solo ci abbandonassimo ai flussi delle immagini televisive che tanto, e tanto poco, ci dicono sulle realtà che un tempo erano distanti da noi e oggi sono a casa nostra, a costruire la percezione immediata e tangibile della globalità planetaria che ci avvolge, ci sostiene, ci condanna. Quelle immagini, come già hanno fatto in occasione della prima Guerra del Golfo più di dieci anni fa, ci tranquillizzerebbero eccitandoci al tempo stesso: eccitazione per la potenza fantasmagorica di una tecnologia che in qualche modo non possiamo non sentire nostra, uscita dai processi dell’intelletto generale planetario di cui ci sentiamo parte; tranquillità per l’assenza di effetti immediati su di noi, per l’assenza di corpi feriti straziati martoriati, che non essendo mostrati su nessuna televisione, su nessun giornale, su nessuno dei siti Internet più frequentati, non esistono, non hanno rilevanza, non hanno cittadinanza – non entrano a far parte della nostra percezione del mondo.
Questa guerra siamo noi. Non possiamo più costruire l’opposizione a essa fidando su un’estraneità ai suoi meccanismi, alle sue giustificazioni, ai discorsi che la descrivono e che la fondano. Certo, possiamo indignarci per l’arroganza la spudoratezza la sfacciataggine del signor Bush Jr. e dei suoi presuntuosi funzionari, che non sentono neppure più il bisogno di giustificare davvero le loro scelte di morte, e possono permettersi di dichiarare che vogliono mettere a ferro e fuoco l’Iraq perché così hanno deciso e basta, e che bisogno c’è di prove provate quando basta il fatto che questi stati canaglia stanno fuori dal sistema, fuori dall’unico discorso planetario legittimato a stabilire la giustizia e la pace. “La guerra giusta non è più, in alcun modo, un atto di difesa o di resistenza. La guerra giusta è divenuta un atto che si giustifica da sé,” perché l’apparato militare che realizza quella guerra è legittimato dall’etica che lo fonda, quella della costruzione di un ordine e di una pace che garantiscono la sicurezza internazionale. Ora noi facciamo bene a tentare di smascherare questa cricca di petrolieri e affaristi texani e l’ipocrisia del loro discorso, ma molti di noi sentono che la loro opposizione alla guerra va al di là della rozzezza e dell’arroganza del gruppo dirigente americano attuale: tanto è vero che eravamo (e continuiamo a essere) contrari anche a ogni ipotesi di guerra “umanitaria,” come fummo contrari alla guerra alla Serbia per il Kosovo, una guerra con la benedizione dell’ONU, attivamente sostenuta e promossa anche da quell’Europa che oggi finge di accreditarsi come contraria alla guerra, ma è contraria solo alla guerra di Bush, e sarebbe invece pronta a farne di altre purché promosse e gestite con maggiori cautele e maggiori schermi ideologici.
Questa guerra siamo noi, perché è la prima, vera guerra dell’era biopolitica che si va dispiegando nel mondo, e della biopolitica noi siamo parte, e parte attiva, come lo siamo dell’Impero, che è il nome che abbiamo dato alle nuove forme politiche e giuridiche legate alla rivoluzione nei modi di produzione. E non possiamo barare con noi stessi. Ora la nuova forma di gestione e di articolazione della società, che possiamo chiamare “biopotere”, “è una forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo.” Questo potere “può imporre un comando effettivo sull’intera vita della popolazione solo nel momento in cui diviene una funzione vitale e integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente.” Questo è il risultato di una nuova produzione che al suo centro non ha più la trasformazione della materia, la creazione e la diffusione delle merci materiali, ma le merci immateriali, e quindi l’attività linguistica, le relazioni umane, gli affetti, e tramite le tecnologie dell’informazione e della comunicazione è in grado di trasformare tutto ciò in valore economico. In questo passaggio, che è il passaggio dalle società disciplinari alle società del controllo, non solo si vanifica tendenzialmente la differenza fra tempo di lavoro e tempo libero (col risultato che molti di noi, volenti o nolenti, sono “al lavoro” per il capitale globale 24 ore su 24), non solo viene meno la differenza tra produzione di merci e produzione della soggettività, ma il controllo del potere “raggiunge la profondità delle coscienze e dei corpi e, a un tempo, la totalità delle relazioni sociali.”
Questa guerra siamo noi (e per combatterla dobbiamo quindi in qualche modo combattere contro noi stessi) non perché faccia leva su atavici meccanismi di violenza belluina di cui tutti, in quanto uomini, saremmo portatori, ma al contrario perché ha motivazioni sofisticate, articolate, raffinate, perché è basata strutturalmente (e non solo per esigenze di comunicazione e di travestimento ideologico) su meccanismi linguistici. Perché in qualche modo siamo tutti complici dell’Impero. Questa nuova qualità della guerra, che si avvia a essere (come è stato detto) una “guerra infinita”, una modalità permanente delle relazioni internazionali, vanificando il classico concetto di nemico, confondendosi con un’interminabile operazione di polizia – questa nuova qualità, dicevo, è adesso in parte mascherata dalla natura arretrata e reazionaria dell’attuale gruppo dirigente Usa che ne sta gestendo la prima massiccia manifestazione. Ma la guerra biopolitica manterrebbe il suo carattere odioso e oppressivo, stabilizzante e pervasivo, sarebbe uno strumento di controllo dei corpi e del linguaggio, anche se fosse gestita in maniera meno arrogante e più attenta ai residui degli antichi meccanismi di mediazione internazionale (l’ONU), anche se fosse giustificata in modo meno altezzoso e se fosse più attenta al consenso. Anche se fosse gestita dalle socialdemocrazie europee.
Ma se la guerra è in qualche modo un effetto ineluttabile della globalizzazione, che cosa ci resta da fare, che cosa possiamo fare per fermarla, per sradicarla, per estirparla dai nostri corpi e dalle nostre coscienze? Non è forse senza speranza questa analisi? Non credo. Sono altri i discorsi di chiusura sulla natura della guerra: per esempio sono quelli che, attenti solo alla dimensione geopolitica e statuale del mondo unipolare uscito dopo il 1989, vedono nello strapotere dell’unica superpotenza l’elemento principale di soffocamento delle alternative, e, intrecciando questa lettura dell’oggi con una raffinata ripresa dell’Apocalissi di Giovanni, non sanno consegnare ad altro che alle “voci” e ai “pensieri” la flebile testimonianza di un’opposizione. Credo invece che radicare la questione della guerra nei cambiamenti reali di paradigmi e di modi di produzione, nell’analisi della fase biopolitica del potere e della società, ci consenta di capire come sottrarre alla morsa dello spettacolo della guerra (che a questo punto è una prosecuzione della produzione con altri mezzi) i corpi e i linguaggi delle moltitudini che materialmente producono l’Impero, e che sono escluse dai suoi meccanismi di funzionamento più segreti. Contro l’Impero può essere scatenato il desiderio immanente dei corpi, che tenda a liberarli dal morbido controllo delle abitudini metropolitane; dentro e contro l’Impero può essere sperimentato e agito un uso improprio, deviato, espressivo, beffardo, dei linguaggi. È quello che proveremo a fare, che proveremo a iniziare, il 15 febbraio a Roma e in tante altre capitali del mondo.
Devo molte delle idee (e tutte le citazioni) di questo articolo ad alcuni libri: Impero di Michael Hardt e Antonio Negri (Rizzoli), Esercizi di esodo di Paolo Virno (ombre corte), Il posto dei calzini di Christian Marazzi (Bollati Boringhieri). L’analisi “unilateralmente geopolitica” criticata alla fine dell’articolo si trova in La guerra di Alberto Asor Rosa (Einaudi).
Articolo apparso originariamente su Socialpress n. unico, febb.-marzo 2003.