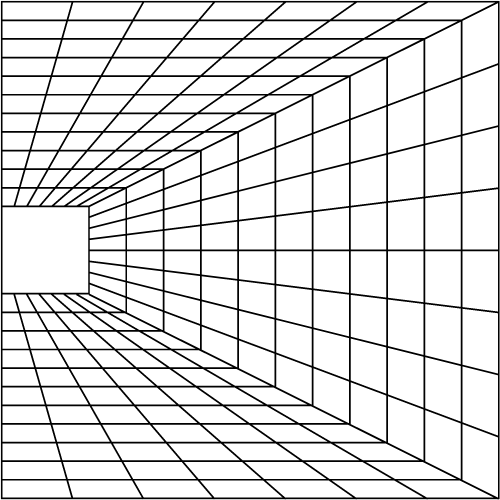Sul finire degli anni ‘90, mentre anche in Italia scoppia la febbre della new economy, chi aveva seguito da vicino nell’arco del decennio l’affermazione di Internet e delle comunità virtuali, decide di cambiare la prospettiva e si interroga piuttosto sul futuro del corpo in un contesto sociale sempre più tecnologico. Nasce così il progetto di Flash Out “corpi e attitudini fuori controllo”, il luogo in cui i corpi mutati, in primo luogo dalle pratiche dell’arte e della performance, potevano prendere forma (non formalizzarsi) e “ high-tech cibernetico, impianti chirurgici, body art e scena fetish potessero incontrarsi in modo poco patinato e non pregiudizialmente rinchiuso nel mondo dell’arte o dello hype mediatico”.
Che cos ‘era Flesh Out? Probabilmente una follia, secondo Caronia: “Una rivista nata nel novembre 1998 col nome di FIesh Art (il riferimento alla quasi omonima rivista di Politi era voluto, ma costui fece causa e ci costrinse a cambiare nome), uscita dall ‘inventività e dalle ossessioni di Fabio Malagnini (a cui mi univano e mi uniscono — molti terreni di riflessione e una salda amicizia)...Una scommessa editoriale intrapresa in un atto di lucida e deliberata incoscienza” ma che (mi piace pensare) lasciò il segno”
La rivista, formato lenzuolo secondo i dettami del tempo, durò due anni e sei numeri in edicola. Attorno alla testata fluttua una “brain salad” di cui fecero parte in modo variabile Andrea Giorgi, Helena Velena, Massimo Giacon e più costantemente Caronia, attraverso il quale arrivano anche in redazione i contributi di Daniele Brolli, Roberto Marchesini, Barbara Martusciello, Fabio Zucchella.
Caronia firma le interviste a Motus (n.1, Novembre / Dicembre 1998) e a Stelarc (n.5, Settembre / Ottobre 1999) , un articolo sull’ artista fanta-mediatico Darko Maver (n.3, Aprile / Maggio 1999) e, sull’ultimo numero, (Flesh Out n.6, Gennaio / Febbraio 2000) il saggio Antonin Artaud, la battaglia del corpo contro il linguaggio che riproduciamo qui di seguito.
Tutti i numeri di Flash Art / Out sono oggi disponibili online grazie a l’Edicola che non c’è, promossa da Agenzia X e Moicana.
(https://archive.org/search?query=creator%3A%22Agenzia+X%22)
Antonin Artaud, la battaglia del corpo contro il linguaggio
[Pubblicato su Flesh Out N. 6, genn.-febb. 2000]
Uno dei passaggi più densi e significativi della seconda metà del secolo XX potrebbe essere contenuto in una trasmissione radiofonica che non ebbe mai luogo, che non fu mai trasmessa cioè, ma fu accuratamente preparata, eseguita, registrata: emessa, insomma, ma non trasmessa. Pour en finir avec le jugement de dieu (Per farla finita con il giudizio di dio) andrebbe forse messa in parallelo con un’altra famosa trasmissione radiofonica, l’invasione del marziani di Orson Welles, di quasi dieci anni prima e in un altro continente. Nel 1938 il geniale e burlesco attore/teatrante/regista americano, appena ventitreenne, terrorizzava il pubblico con il racconto di un’inesistente invasione spacciata per reale e costruiva le fondamenta del suo futuro amaro successo; nel 1947 il cinquantunenne Antonin Artaud, pochi mesi prima di morire, concludeva la sua faticosa parabola terrena con la testimonianza più viva e bruciante della sua ribellione, una testimonianza che nessuno, a parte i suoi pochi amici, ascoltava. Erano però, tutte e due, strategie diverse ma non opposte, quasi complementari, per tendere una trappola esiziale ai padri e all’intera società, e per ritorcere il linguaggio contro se stesso. Ecco perché esse, oggi, sono più attuali che mai.
Antonin Artaud era tornato a Parigi nel 1946, dopo nove anni di internamento in manicomio, durante i quali le privazioni della guerra si erano sommate alle durezze del trattamento medico riservato ai malati di mente, compresa l’allora nascente e ripugnante pratica dell’elettrochoc. Era entrato in ospedale psichiatrico alla fine del 1937, dopo essere stato arrestato in Irlanda in seguito ad avvenimenti mai chiariti. Il suo volto intenso e obliquo, il volto che era stato fotografato da Man Ray, che era comparso in tante commedie e film degli anni Venti e Trenta, come il Napoléon di Abel Gance e La passion de Jeanne d’Arc di Carl Dreyer, era stato mutato dagli anni, dalla reclusione e dai maltrattamenti in una maschera di sofferenza e forse di disillusione: aveva perso l’ambigua malinconia che aveva in gioventù, ma non si era arreso al cinismo e aveva forse acquistato una sorta di dolente fierezza. No, non si era arreso Artaud, anzi sembrava voler riscattare gli antichi insuccessi teatrali, la grama vita del suo Théâtre Alfred Jarry nel 1927/28, il fiasco nel 1935 di I Cenci, la tragedia che doveva realizzare la prima vera esperienza di “teatro della crudeltà”, come teorizzato negli scritti che compongono Il teatro e il suo doppio, libro pubblicato nel 1938. Pour en finir avec le jugement de dieu doveva realizzare più compiutamente ciò che non gli era riuscito dieci, venti anni prima: “spezzare il linguaggio per raggiungere la vita” [“Il teatro e la cultura”, Il teatro e il suo doppio, 132]. L’occasione era un ciclo di trasmissioni per la Radiodiffusion française intitolato La voix des poètes ̧ La voce dei poeti. Artaud aveva scritto dei nuovi testi, aveva accuratamente progettato il montaggio della trasmissione, che prevedeva letture (eseguite da lui stesso e dai suoi amici Roger Blin, Paule Thévenin, Maria Casarès), effetti sonori (bruitages) prodotti con xilofono e percussioni, vocalizzazioni (glossolalie), grida inarticolate. Attraverso un mezzo tecnologico come la radio, in apparenza monco, diretto al solo udito, era in realtà il corpo che faceva irruzione in questa scena teatrale virtuale. Quindici anni prima che McLuhan definisse la radio come “medium caldo” e la paragonasse a un tamburo tribale, Artaud aveva intuito e praticato l’uso più dirompente ma anche più proprio di questo mezzo. La violenza della voce, della phoné, entrava in competizione e in opposizione con il logos, con la dittatura della parola articolata e organizzata, in una bruciante sintonia con le intenzioni della trasmissione: farla finita non solo con il giudizio di dio (sempre rigorosamente minuscolo), ma con il giudizio in genere, con il giudizio definitivo, le jugement dernier, il pronunciamento del padre, degli uomini e della società che determina l’inclusione o l’esclusione dalla comunità. Certo, c’era innanzitutto una molla personale che spingeva Artaud a questa ribellione: era la riconquista del suo nome, di una identità che aveva rifiutato durante il primo periodo dell’internamento, quando sosteneva che Antonin Artaud era morto nel 1939 e che il suo posto era stato preso da Antonin Nalpas (Nalpas era il cognome della madre). Ma a poco a poco la coscienza di sé era tornata: durante gli anni trascorsi a Rodez, fra il 1943 e il 1946, nonostante la tortura dell’elettrochoc, Artaud aveva ripreso a scrivere dapprima con la mediazione della traduzione (il capitolo 6 di Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, quello su Humpty Dumpty), poi con le lettere e i diari, e aveva alfine riconquistato il proprio nome. Ma proprio perché questo reinsediamento aveva tutto l’aspetto di una rinascita, egli lo accompagnava con una orgogliosa rivendicazione di autonomia, così radicale da comportare un azzeramento della propria storia personale e biologica e una riscrittura delle proprie origini tutta interna a se stesso: “Io, Antonin Artaud, sono | mio figlio, | mio padre, mia madre, | e io.” [Ci-Gît, XII, 77] Questa rinascita, però, Artaud non la metteva al servizio di una dimensione solo interna alla propria storia, voleva farne da subito uno strumento di proiezione all’esterno, di scandalo, di battaglia. “Il dovere dello scrittore, del poeta,” diceva in una lettera a René Guilly, “non è quello di andare a rinchiudersi vigliaccamente in un testo, in un libro, in una rivista da cui non uscirà mai più, al contrario è quello di uscir fuori per scuotere, per attaccare lo spirito pubblico” [XIII, 136]. È il corpo, certo, il protagonista di questa scossa e di questo attacco, ma è un corpo radicalmente trasformato, scomposto e ricomposto nel terremoto del ripudio di ogni dualismo, di ogni tradizione di ordine e compostezza.
Chi sono?
Da dove vengo?
Sono Antonin Artaud
e che io lo dica
come lo so dire
immediatamente
vedrete il mio corpo attuale
cadere in pezzi
e raccogliersi
sotto diecimila aspetti
notori
un corpo nuovo
dove non potrete
mai più
dimenticarmi.”
[Post-scriptum a Le Théâtre de la cruauté, XIII, 118]
Che cos’è questo “corpo nuovo” con il quale nessuno potrà più dimenticare Antonin Artaud? È quello che egli chiama “corpo senza organi”, una nozione ardua e affascinante, “o piuttosto una pratica, un insieme di pratiche,” come hanno scritto Deleuze e Guattari, che al corpo senza organi hanno dedicato una sezione del loro Millepiani. Il corpo senza organi è la riconquista di una prossimità con la propria esperienza, è il tentativo di colmare la distanza dell’assenza, è il rifiuto dell’estraneità e della tradizione metafisica occidentale. Come ha scritto Jacques Derrida, “Artaud diffida del corpo articolato, così come diffida del linguaggio articolato, del membro così come della parola, in un modo unico e uguale, per una sola e medesima ragione. Perché l’articolazione è la struttura del mio corpo e la struttura è sempre struttura d’espropriazione. La divisione del corpo in organi, la differenza interna alla carne apre la carenza, attraverso la quale il corpo si fa assente a se stesso, dando a intendere di essere, o credendo di essere, lo spirito.” [“Artaud: la parole soufflée”, la scrittura e la differenza, 242]. Per Artaud si tratta letteralmente di rifare l’anatomia dell’uomo, perché qualcuno (e quel qualcuno è ciò che egli chiama dio), attraverso la differenziazione organica preme su di lui, gli sottrae la parola, coarta la sua libertà.
L’uomo è malato perché è mal fatto.
Bisogna decidersi a metterlo a nudo per raschiargli via quell’animalculo che gli prude mortalmente,
dio
e con dio,
i suoi organi.
E legatemi se volete,
ma non c’è nulla di più inutile di un organo.
Quando gli avrete fatto un corpo senza organi,
lo avrete allora liberato da tutti i suoi automatismi e reso alla sua autentica libertà.
Allora gli insegnerete di nuovo a danzare all’inverso
come nel delirio delle balere
e l’inverso sarà il suo autentico luogo.”
[Pour en finir avec le jugement de dieu, XIII, 103-104]
Corpo senza organi, suono senza parola, discorso senza ordine: che cosa voleva indicarci Antonin Artaud con questa serie incalzante di paradossi? Le sue intenzioni erano sempre state chiare: erano quelle del viaggio in Messico del 1936, al paese del Tarahumara in cerca del rito del peyotl, erano quelle che avevano ispirato la sua contraddittoria e polemica presenza nel mondo del teatro, erano quelle che avevano sostenuto la sua breve militanza nel movimento surrealista tra il 1924 e il 1926. Scelte e strumenti potevano cambiare, ma il programma restava quello: “spezzare il linguaggio per raggiungere la vita”. Artaud, la cui vita fu segnata sino dalla prima giovinezza dalla malattia e dal dolore fisico e mentale, aveva una percezione nettissima del potere consolatorio e mistificatorio della parola. Ma scavando e rivolgendo in continuazione il luogo oscuro e torbido in cui essa, la parola, si origina e prende forma in ciascuno di noi, questo luogo per lui divenne ben presto trasparente. Poteva leggervi dentro come pochi altri hanno saputo fare: e la sua angoscia, allora, fu che quella trasparenza non ne annullava affatto il mistero.
E ve l’ho già detto: niente opere, niente lingua, niente parola, niente spirito, niente.
Niente, se non un bel Pesa-Nervi.
Una sorta di stazione eretta e incomprensibile in mezzo a tutto nello spirito.
E non sperate che dia un nome a questo tutto, vi dica in quante parti si divida, che peso abbia, che mi dia da fare, mi metta a discutere, e, discutendo, mi perda e così senza saperlo mi metta a PENSARE – (…)
Ve l’ho già detto che non ho più la mia lingua, e non è una ragione perché perseveriate, vi ostiniate nella lingua.
Ma via! Sarò capito tra dieci anni dalle persone che faranno quel che fate voi oggi (…)
Allora si capirà perché il mio spirito non è lì, allora si vedranno tutte le lingue inaridire, tutti gli spiriti disseccarsi, tutte le lingue indurirsi, le figure umane s’appiattiranno, si sgonfieranno, come aspirate da ventose disseccanti, (…)
allora tutto questo sarà trovato giusto,
e non avrò più bisogno di parlare.”
[Il Pesa-Nervi, in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, 44-45]
Ci sono voluti più di dieci anni, ma oggi, all’inizio dell’era digitale, Artaud si ripresenta a noi con una nettezza e un’incisività del tutto nuove. È nella dimensione apparentemente immateriale e sterilizzata delle reti telematiche che sta nascendo un corpo senza organi, un corpo in prima istanza virtuale, una sterminata potenzialità capace però di attualizzarsi e di tradursi in carne, anche se forse una “nuova carne” come quella descritta nei film di Cronenberg. Artaud aveva già percorso, seguendo le vie sottili e pulsanti dei suoi nervi, il cammino che portava dalla virtualità all’attualità, dall’immaginario alla carne. “… una volontà superiore e cattiva attacca l’anima come vetriolo, attacca la massa parola-e-immagine, attacca la massa del sentimento, e lascia me ansimante, come sulla soglia della vita. E di quella volontà, adesso, supponga che io risenta fisicamente il passaggio, che mi scuota con un’elettricità imprevista e improvvisa, un’elettricità ripetuta.” [Lettera a Jaques Rivière del 6 giugno 1924, in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, 25] È da quel percorso che nasceva la sua insofferenza per i letterati, per la letteratura, per il “teatro pietrificato”, quello che si fissa su un linguaggio particolare (parole scritte, musica, luci, suoni) e non sa “dare un nome alle ombre e guidarle”: la sua insofferenza per le forme, che non sono capaci di afferrare “il nucleo fragile e irrequieto della vita”. “E se c’è qualcosa di diabolico e di veramente maledetto nella nostra epoca, è di attardarsi artisticamente sulle forme, invece di essere come suppliziati che bruciano e fanno segni sui loro roghi.” [“Il teatro e la cultura”, in Il teatro e il suo doppio, 133].
Il teatro gli interessava perché era il luogo in cui poteva essere combattuta la mistificazione della parola, la separazione della cultura dalla vita in cui egli vedeva il tratto distintivo dell’occidente: perché “fra tutti i linguaggi e tutte le arti, [il teatro] è il solo le cui ombre abbiano travolto i loro limiti. Si può anzi dire che esse sin dall’origine non abbiano tollerato limiti.” [“Il teatro e la cultura”, 131-132] Ecco perché Artaud è inutilizzabile per un rinnovamento del teatro, come delle arti in genere, che sia ancora tutto rinchiuso all’interno dell’orizzonte della rappresentazione. La straordinaria battaglia contro il linguaggio che Artaud sperimentò sul proprio corpo ci può dire qualcosa solo se siamo interessati al superamento dell’arte come dimensione separata, se vogliamo pensare e praticare un livello dell’espressione che lavori dentro i processi di produzione del senso, individuali e sociali, se vogliamo vivere gli squilibri indotti dalla tecnologia contemporanea come occasione di liberazione dei corpi e non di asservimento. Allora il corpo di Artaud che danza all’inverso, che scuote le deboli certezze della parola e si fa travolgere dall’ombra, può essere più vicino di quanto non si creda al corpo ibridato dalle tecnologie, al corpo come campo di possibilità e non come destino biologico. “Tutto ciò che non è nato può ancora nascere, purchè non ci si accontenti di essere semplici organi di registrazione.” [“Il teatro e la cultura”, 133]
Bibliografia
Antonin Artaud, Oeuvres completes, Editions Gallimard, 26 voll. [numerati in cifre romane].
Antonin Artaud, Al paese dei Tarahumara e altri scritti, Adelphi 1966.
Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi 1968.
Lewis Carroll, Humpty Dumpty. Traduzione francese di Antonin Artaud, L’arve e l’aume. Versione italiana di Guido Almansi e Giuliana Pozzo, Bindolo Rondolo. A cura di Carlo Pasi, Einaudi 1993.
Jacques Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi 1990.
Carlo Pasi, Artaud attore, La casa Usher 1989.
Ida Savarino, Antonin Artaud nel vortice dell’elettrochoc, Sensibili alle foglie 1998.
Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Costa&Nolan 1998.
Gabriele Perretta, Pour Artaud. Neuralità e delirio nell’arcipelago dell’introspezione, Edizioni dell’ortica, s.d.